Non esiste l’innovatore
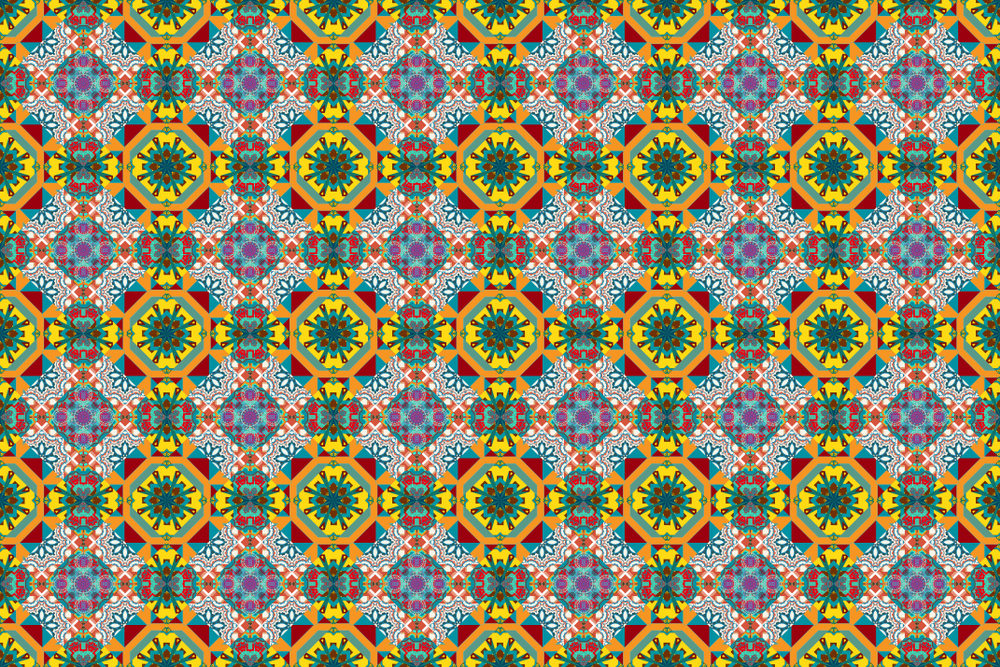
Non esiste l’innovatore, esistono gli innovatori. Al plurale.
Per molto tempo ho creduto nel mito della persona che si fa da sé. L’esperienza e lo studio mi hanno aiutato a capire che nessuno può davvero realizzare qualcosa di notevole da solo. Un antico detto africano dice che “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. Allo stesso modo, per portare a manifestazione un’idea serve una comunità. Dopotutto, gli umani sono una specie sociale e, nonostante il nostro amore per il mito dell’eroe che uccide il drago tutto da solo, nessuno può davvero ottenere qualcosa di significativo da solo. Dietro ogni eroe c’è una sfera sociale senza la quale non esisterebbe affatto. Come afferma perfettamente Greg Satell nel suo libro Mapping Innovation: A Playbook for Navigating a Disruptive Age, “qualsiasi innovazione significativa implica un’incredibile varietà di problemi che devono essere risolti, dalle sfide teoriche e ingegneristiche agli ostacoli di produzione e distribuzione. Non esiste ‘la risposta semplice’ e nessuna persona, nemmeno una singola organizzazione, può fornire tutte le risposte da sola”.
Nel 1998, il sociologo Randall Collins ha pubblicato un libro intitolato The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change, il risultato di venticinque anni di ricerca per capire come pensatori e idee si fossero connessi attraverso la storia e i continenti. Dopo aver mappato oltre 3000 filosofi e matematici da ogni parte del mondo e di diversi periodi storici, ha scoperto che i pensatori creativi tendono a raggrupparsi. Può essere per collaborare o competere: qualunque sia il motivo, si motivano e si ispirano a vicenda. Pertanto, la riuscita di uno di loro non può essere isolata dal suo gruppo. Basti pensare all’età d’oro della fisica, tra il 1840 e il 1930. In questo gruppo c’erano menti eminenti come Einstein, Planck, Tesla, Marconi, Westinghouse, Madame Curie, i fratelli Wright, Emmy Noether, Edison e altri. Il successo di ciascuno di loro deve considerare l’influenza di tutti gli altri.
Eppure, la narrazione dominante ci racconta che le persone che ottengono risultati importanti ci riescono solo grazie al loro talento innato e al loro impegno straordinario. Il mito della persona che si è fatta da sola. Nel suo Trattato di economia eretica, Thomas Porcher spiega lucidamente perché questa narrazione è così diffusa:”L’esigua percentuale di individui che si accaparra la maggior parte delle ricchezze ha tutto l’interesse a far credere di meritarlo. Non c’è modo migliore, per prevalere sugli altri, che far passare come verità inconfutabile l’idea che sia l’individuo il solo artefice del proprio destino e che soltanto dal suo comportamento dipendano il successo o il fallimento”. In quasi tutte le biografie dedicate alle persone di successo in ogni campo, dalla politica, all’economia, dallo sport all’innovazione tecnologica, la chiave principale del successo ottenuto viene cercata soprattutto nella loro personalità, molto meno negli ecosistemi che hanno permesso loro di ottenere i loro risultati. “Se lo spirito imprenditoriale fosse l’unica caratteristica necessaria al successo, i paesi in via di sviluppo sarebbero i più ricchi del mondo. Gli abitanti di questi paesi non dispongono di grandi imprese nazionali che possano impiegarli (spesso lavorano per multinazionali con ruoli qualificati e poco retribuiti). Non hanno accesso a finanziamenti per avviare la propria attività (a eccezione del microcredito con tassi di interesse molto elevati, che consentono di realizzare solo micro-progetti). Nel caso siano dipendenti pubblici, spesso i salari sono bassi e pagati in ritardo. Quindi, per colmare le carenze istituzionali, sviluppano parallelamente un’imprenditoria di sopravvivenza con un’ingegnosità impressionante”.
La mia esperienza diretta con luoghi lontani dai centri abituali dell’innovazione globale conferma quanto scrive Porcher. L’ingegnosità e intraprendenza che vedo e respiro in quei luoghi è straordinaria. Eppure è raro per loro raggiungere il livello di successo degli innovatori e imprenditori di cui leggiamo le biografie. Questo perché, come ci ricorda Porcher: “Il successo individuale è anzitutto collettivo perché dipende dalle politiche messe in atto dalle istituzioni e dal capitale produttivo, umano e sociale di un paese”. A queste considerazioni di Porcher vorrei però aggiungere il valore profondo della comunità. L’innovazione è il risultato di una comunità e non deve ingannare il fatto che la nostra passione per il mito dell’eroe ci porti a puntare il riflettore su una sola persona. La comunità è il vero innovatore e per questo, quando parliamo di innovazione, dovremmo parlare sempre al plurale. Ce lo ricorda anche Peter Block nel suo Community.
Il fatto che il senso di comunità abbia un’importanza pratica ha trovato probabilmente la sua migliore affermazione nel lavoro di Robert Putnam, esposto nel suo libro Bowling Alone. Egli ha scoperto che la salute degli individui, il rendimento scolastico, la forza economica locale e altre misure del benessere della comunità dipendono tutte dal livello di capitale sociale che esiste in quella comunità. La geografia, la storia, un’ottima leadership, bei programmi, i vantaggi competitivi, o qualsiasi altro fattore che usiamo tradizionalmente per spiegare il successo fanno solo una differenza marginale per la salute, l’istruzione o la forza economica di una comunità. Il benessere di una comunità ha semplicemente a che fare con la qualità delle relazioni, con la coesione che esiste tra i suoi cittadini. Putnam lo chiama capitale sociale. Come abbiamo illustrato in Impatto, per creare innovazioni che contribuiscano all’evoluzione dobbiamo integrare tutti gli strati della dimensione umana. E il capitale sociale è uno di questi.
Fabio Salvadori

